S E I C E N T O
SANZIONATORIO
 |
Archivista dei documenti curiali, Nino Allaria Olivieri ha condotto numerose raffinate ricerche delle quali, negli Anno Novanta, ha voluto pubblicare interessanti tratti su LA VOCE INTEMELIA, per ricordarci gustose curiosità sulle nostre radici, databili in specie al Seicento; quando la giurisdizione del Comune ventimigliese comprendeva gli ampi territori, con Airole, in Val Roia e tutta la bassa Val Nervia. Amministrava importanti borgate agricole, conosciute come le Otto Ville: Camporosso, San Biagio, Vallecrosia, Sasso, Vallebona, Borghetto, Soldano e Bordighera, Confinava a levante col comune di San Römu, a nord coi comuni di Dolceacqua e Penna, a ponente col torrente Garavano, alle porte di Mentone.
In quel periodo, per mantenere l’ordine pubblico, sia il Comune, come pure la Curia che ospitava, emanavano continuamente decreti, sanzioni e balzelli che venivano fatti rispettare dal “braccio secolare”, una commistione di funzionari non necessariamente laici, assai inclini all’indottrinamento e sovente alla soperchieria. Metodi non facilmente comprensibili dal nostro attuale modo di pensare. Proprio per questo i lavori di don Allaria sono significativi. |
TRISTE NATALE 1613
di Nino Allaria Olivieri
 |
Era la vigilia del Natale dell’anno 1613. La notte fonda e gelida rivestiva tutta la città; il campanone della Comunità aveva, da tempo, chiamato alla Cattedrale il Parlamento, il Capitanio e il popolo. Don Paolo Porro, chierico aspirante al sacerdozio e inserviente ai canonici, inutilmente cercava la talare delle solennità. Ricordò di averla consegnata un mese prima per un rammendo a Maria, sarta del vicolo del Forno. Uscì di casa in abito civile per andarne alla ricerca; giunto al termine del vicolo due ministri della giustizia di ronda notturna lo fermarono e lo dichiararono in arresto per avere violata l’ordinanza dell’eccellentissimo suo e loro vescovo. Don Paolo si qualificò “quale rampollo di nobile famiglia e disse la ragione dell’essere in istrada a notte avanzata”. I ministri non vollero sentire ragione alcuna:”avrebbe dovuto sapere o ricordare del decreto del vescovo Spinola, che per tanta mancanza li autorizzava a dichiarare lui o qualsiasi prete prigionieri e di subito rinchiuderli nelle carceri del Vescovo”. Aveva violato l’articolo due del decreto, che proibiva ai preti e religiosi di circolare nelle notti “senza lumi”. Fu condotto nella sala prigione del vescovo; poco importava se fosse quella la notte del Natale. Saputo dell’accaduto Giovanni Lavagnino, cavaliere del Capitanio e amico della famiglia Porro, ricorse presso il vescovo perché “per essere Natale doveva il chierico servire i canonici e l’Altare per onorare Dio, ma per aver disatteso al suo decreto, lo avrebbe giudicato e punito quanto prima”. |
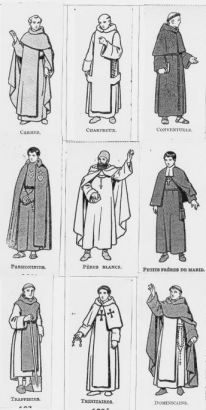 |
Quali fossero i pensieri del malcapitato chierico è bene lasciarlo alla fantasia. Certo si è che, tra un salmodiar e l’altro, una particolare invocazione salì verso quella grotta ove Maria era in attesa e Gesù stava per venire tra gli uomini. Del processo e delle pene non restano notizie; unito al verbale di arresto trovò il famigerato decreto datato a dì primo di febbraio 1612. Richiamarlo e rileggerlo non solo è conoscere la violazione in cui, involontariamente, incappò il chierico, ma è rivivere una pagina di quella riforma che lo Spinola operò nel clero di allora, non sempre di vita timorata e sottomesso a Lui superiore e Padre. Recita il decreto: “Per vigor delle presenti diamo facoltà a Gio Lavagnino, cavaliere del Capitanio di Ventimiglia e suoi ministri di giustizia, che ritrovando, tanto di giorno come di notte, preti di qualsivoglia grado con armi proibite, tanto in atti scandalosi, debbano farli prigioni e condurli alle nostre carceri; li ministri oltre il guadagno delle armi, saranno soddisfatti alla tassa della nostra corte et ad arbitrio secondo i delitti. 2) Diamo inoltre facoltà alli sopradetti Ministri che ritrovano di notte, cioè le due, alcun prete senza lumi debbano condurli inanzi a noi in quell’istante, li quali daremo di nostra borsa la degna mercede. 3) Per ultimo o confirmando il nostro Decreto generale circa l’osservanza delle feste di precetto, diamo facoltà et autorità alli stessi cavallini e ministri di giustizia di dover eseguire contro delinquenti e giusto il quale saranno ricompensati”.
|
Il Vescovo nel corso della sua reggenza fece grande uso di altri decreti stillati con energia e determinazione; punì, anche se non dimenticò la misericordia, canonici, parroci e clerici. Fu duro contro gli inosservanti dei decreti sulla liturgia; rinchiuse per due mesi nelle carceri per aver, nella notte di Natale, “ufficiato con modi pagani” il parroco di Saorgio; sospese due curati per “gridar robusta voce, le parole della Consacrazione” e ai canonici “quasi stanchi nell’ufficiare” minacciò sospensione a divinis.
Decreti, punizioni erano necessarie. (Archivio Curia Vescovile-Ventimiglia)
LA VOCE INTEMELIA anno LIV n. 12 - dicembre 1999

La peste e “l’aceto dei sette ladri”
di Nino Allaria Olivieri
Dal mese di giugno dell’anno 1656 al maggio del 1657 la calamità della peste investì tutta la Liguria. Genova contò i propri morti in numero di novemila; Savona, Oneglia, San Remo non furono meno colpite.
Ventimiglia e alcuni villaggi a fondo valle, anche se non in numero eccessivo, dovettero piangere i propri morti: i registri parrocchiali, riletti di sfuggita, enumerano i decessi «di uomini e donne adulti duecento ottanta quattro». Le tombe gentilizie e patronali erette nelle varie chiese cittadine e il cimitero presso San Giovanni al Cavo non furono sufficienti e non pochi cadaveri rimasero lungo tempo in attesa di sepoltura.
Il locale parlamento si rivolse al vescovo Promontorio affinché indicasse un nuovo sito idoneo nella impossibilità di reperire alcunché attorno e fuori le mura della città, dopo divergenze inutili, si indicò uno spiazzo presso la Bastia, oltre il Roia. Di facile soluzione fu la sepoltura dei morti nelle masserie fuori le mura: il vescovo ordinò fossero sepolti «in loco, fuori abitato, con sopra un segno di croce».
Al problema cimitero si aggiunse l’opera caritatevole e dovuta del trasporto e del rito della sepoltura che con suo decreto il vescovo ordinò «provvisoriamente sia come rito solo la santa aspersione». All’acuirsi della calamità altro problema fu il reperire uomini atti al prelievo dei cadaveri.
Le confraternite di San Giovanni (Bianchi) e della Buona Morte (Neri), il cui primario fine era accompagnare i fratelli e i poveri cessarono, in parte, la dovuta opera di misericordia.
La paura aveva preso il sopravvento. Gli abbienti e chi aveva terre fuori città vi cercarono rifugio. L’aria pura e il vivere solitario avrebbero risparmiato sia il terrore del veder morire, sia la vita. La città di Ventimiglia poteva dirsi deserta.
Costretti dal giuramento e da umanità operarono alcuni medici, due sacerdoti e un numero imprecisato di miserevoli che alcune carte del tempo ricordano con il nome di “Scioatori”, cioè “Becchini”.
I becchini, segnati di una croce bianca sulla schiena e accompagnati da due messeri, anch’essi crociati in azzurro, percorrevano due volte al giorno le strade di Ventimiglia, annunziando, a chi occorresse, la loro opera con il ritmato suono di un campanello. Non mancavano di prudenza. Il volto loro era coperto da una maschera nera terminante a becco di uccello (forse da questa maschera il nome di becchino). Pure i medici usavano prudenza. Da varie carte di archivio se ne ricava una ben buffa fotografia. Chiamati presso un malato, e i malati erano per lo più di nobile famiglia locale, indossavano una lunga veste di marocchino, sigillata al collo e dai polsi stretti, una maschera con lungo e capace becco di uccello entro cui era una spugna o cotone imbevuto di varie essenze aromatiche; anche le mani erano inguantate e impugnavano una bacchetta di ferro con lama per l’apertura di eventuali bubboni.
Per prevenzione ogni medico faceva uso di particolari e studiate essenze. Il chirurgo Bono consigliava ad un suo collega l’uso dello “aceto dei sette Ladri”, composizione, al tempo, in uso presso i medicastri dei paesi e da lui appresa da una certa Sommariva «inquisita ed assolta nei passati processi». «Deve essere di buon rimedio se la poveretta non fu condannata».
Lo “Aceto dei sette ladri” era un assieme di erbe alcune aromatiche, altre velenose e diuretiche, che rubate in sette orti e da sette ladri, poste per sette giorni a macerare in aceto avrebbero, per virtù di fermentazione, impedito il germe pestifero di entrare dalla bocca e dalle nari. Le scuole mediche del tempo consigliavano la Teriaca, antidoto reale e universale di Andromaco, protomedico di Nerone imperatore.
Tanta e tale era la prudenza che di essa il padre Anton Maria, agostiniano scalzo, testimonio occulare della peste in Ventimiglia e Genova scriveva: «Sanitari, infermieri, ministri del culto adempivano il loro ufficio stando ricoperti con cappe incerate. Procedevano calzati per non calpestare cose infette. Odoravano spongie imbevute di aromi. Gli ambienti erano disinfettati, facendo accendere qualche fascio di ginepro. Era poco meno che cascare nell’acqua senza bagnarsi o nel fuoco senza abbracciarsi».
LA VOCE INTEMELIA anno LV n. 3 - marzo 2000

Uno strano reato
di Nino Allaria Olivieri
I documenti processuali contro Andrea Vacca del Casale Sant’Andrea, valle San Bartolomeo, datati il 12 gennaio 1612 recano in frontespizio la dicitura: “Absolutio de reato mintionis”.
Era Andrea uno di quei uomini con la mente più rivolta alla terra del piccolo podere che alla volta del cielo. Di fede semplice, ma timorato, invocava il cielo a sbalzi, pronto ad offendersi si lo si tacciava di incredulità.
Ma la mattina del 23 dicembre 1611, in previsione dei giorni santi, riempito un canestro di uova, si avviò alla volta di Ventimiglia. Aveva udito che nella cattedrale due padri di San Francesco, fatti venire da Genova dal vescovo Spinola, tenevano illuminati sermoni e che il popolo accorreva con entusiasmo ad ascoltarli. Se il desiderio di vedere, poi giudicare, era uno, ben altro era la ragione: occasione ottima per smerciare sulla piazza le uova del suo pollaio. Nella mattinata fredda si mise in cammino. Giunto a Porta Nizza incappò negli sbirri dell’annonaria; dieci furono le difficoltà: licenza e tempo vietato di vendere sulla chiappa. E se non poteva vendere avrebbe ascoltato i decantati predicatori. La cattedrale era zeppa all’inverosimile: “li banchi pieni, le corsie pure, gente in ogni loco”. Andrea, che nell’entrare aveva depositato a lato della porta piccola di destra la merce, uscì per lanciarvi un’occhiata. Vide li sbirri sollevare il lino che copriva il cestino, rientrò tutto pensieroso.
La predica andava per le lunghe; un forte desiderio di scampare acqua lo prese “causa il forte freddo” dirà al giudice.
E uscì. Sulla piazza i soliti sbirri in confabulazione concitata, lungo la via che in discesa menava all’Episcopio neppure tentare.
Sulla piazza neppure osare e svoltò a destra sulla strada che conduce alle Clarissse. Un posto c’era e vi si accostò: poteva finalmente liberarsi dalla necessità. Ma un urlo lo interruppe: gli sbirri correvano contro di lui.
Comprese di essere in fallo e cercò la salvezza stendendosi corpo morto sul lungo gradino che affiancava il lato destro della cattedrale. Quel banchetto era sacro e godeva dell’immunità; non lo avrebbero da lì strappato senza il permesso della Curia. Andrea si sbagliava. Lo presero per la fascia delle brache, lo stirarono per i calzoni. Dovette cedere. Inutili gli urli e le mille proteste. Condotto all’ufficio della Giustizia fu accusato di “atti osceni e contro luogo sacro”.
Era giorno di festa; fu lasciato libero con promessa di presentarsi cinque giorni dopo per “sentire condanna delle sue malefatte e giusta condanna da parte del fisco curiale”.
Andrea si portò sulla piazza. Il cestino era ancora al suo posto, ma mani operose avevano tolto una mezza dozzina di uova.
Cinque giorni dopo Andrea puntuale si presentò alla Curia. Ad inquisirlo trovò il vecchio cancelliere, buon giudice e onesto prete, che in breve con l’aiuto di alcuni testimoni imbastì gli atti, e poiché il reato poteva annoverarsi tra i codicilli di stretta necessità e il fatto non comportava reato, Andrea se ne uscì assolto.
Negli atti si legge: “chiese perdono e si pentì di quello che aveva fatto”... Perché non indagare, con tutta malizia, dei pensieri e con essi dei “moccoli” lanciati contro gli sbirri lungo la strada del ritorno ? Forse, alcuni di essi partirono a favore dei due frati predicatori. (Archivio Vescovile)
LA VOCE INTEMELIA anno XLVII n. 4 - aprile 1992
Le caciotte di Fra’ Michele
di Nino Allaria Olivieri
È l’anno 1621, a dì 12 del mese di giugno. In Ventimiglia, presso lo scanno di Giustizia del Fisco della Curia, Fra’ Bernardo da Genova, guardiano del convento dell’Annunziata, con fare poco consone alla veste e con voce imperiosa, impone all’Arcidiacono della cattedrale, giudice di turno presso la Curia, di emettere un decretale monitoriale contro gli abitanti di Piena. E Fra’ Bernardo determinato a fare luce e giustizia: se i pienaschi sono colpevoli vengano puniti e il convento rientri nei suoi diritti e se Fra’ Michele, suo frate servente, ha usato poca prudenza ne riceva un duplice castigo.
Era Fra’ Michele servitore al Convento, cuoco, faccendiere e questuante. Avendo egli terminato il giro di questua in Ventimiglia e casolari adiacenti, il 24 giugno, per imposizione del guardiano se ne parte, passato il mezzogiorno, alla volta di Briga. Ha ordine di incassare due censi in denaro e in natura, dovuti per affitto di pascoli, lasciati “ab immemorabile” in legato al Convento e «questuare di porta in porta presso i buoni montanari pastori».
E la prima volta che il mite Fra’ Michele si accinge a tanto incarico, incarico che sarà un dovere ma anche un innocente periodo di svago e di conoscenze. Sella l’asino bianco del convento, carica due ceste e alcuni stracci e una gorga per attingere acqua lungo il percorso. Fuori le mura di Ventimiglia si sofferma presso l’Oratorio dei Varaje; riprende a salire verso il Passo del Trasforco e, proseguendo sotto un sole cocente, giunto alla Colla, verte e si reca in Airole. Una fuggiva questua e resta il tempo per risalire e trascorrere la notte in Valdolino. Il 25 riprende il cammino: giunge al Pilon, sfiora l’abitato di Piena e oltrepassato Brelio, a notte fonda, frate e asino, riposano presso conoscenti in Briga.
Il risveglio è infelice: pioggia insistente e nebbia. Fra’ Michele non si allarma; passa di vicolo in vicolo, bussa ad ogni porta; incassa dai fratelli Alberti i due censi; anche le offerte sono generose: grano, segale, spelte e formaggio fresco. Fra’ Michele è uomo di praticità; insacca i frumenti e li consegna alla Parrocchiale, lui o altri li avrebbero ritirati. Ripartirà il giorno dopo con buona quantità di formaggi. Nel far ritorno sosta in Piena in località detta “La Colletta” uno spiano fuori le mura. Sullo spiazzo un gruppo di uomini assapora la brezza estiva e alcuni fanciulli vi si trastullano.
L’arrivo e la presenza del frate incuriosisce. Fra i presenti il cap. Gerolamo Gastaldi, detto “il Giacchetta” è il più incuriosito e chiede a Fra’ Michele se nei cesti rechi «moschatelli (susine gialle) perché i fraticelli debbono di esse cibarsi per la salute del corpo e delle loro anime». Fra’ Michele tace, forse offeso.
Il Gastaldi introduce la mano nei cesti e ne estrae fieno e formaggi. Dirà durante il processo: «et io retraendo la mano e sentendo esser formaggi, venne fuori un poco di fieno nel quale ritrovo tanto formaggio ossia toma salata di grossezza come una noce; le quali comportii fra tre o quattro figlioli che erano lì presenti dicendo questo: è la vostra ventura».
Fra’ Michele non mosse ciglio e riprese il suo andare. Giunto al Convento narrò dell’accaduto e delle mali espressioni del cap. Gastaldi. Al guardiano sorsero non pochi dubbi: Che un capitano abbia avuto tanto ardire ? Quale il numero delle tome sottratte ? … e se fra’ Michele avesse mentito ? Per “tranquillità di coscienza et a bene del convento” non restava che l’arma santa del Monitoriale solenne contro i Pienaschi.
L’arcidiacono, con molta riluttanza, lo scrisse; venne proclamato in Piena e in tutte le chiese della diocesi per lo spazio di tre domeniche. All’udirlo il cap. Gastaldi, buon cristiano, anche se burlone da mille risme, “a scarico di propria coscienza e a nome della verità” si reca in Ventimiglia e narra dell’accaduto “toccando li santi evangeli e professando l’atto di fede”.
Il processo dura tre giorni: inquisizioni e deposizioni di testi. Fra’ Michele non è presente; per ordine di Padre Bernardo «ei resta consignato entro il convento per lo spazio di giorni quaranta». All’arcidiacono non resta che dichiarare a non doversi sentenziare «e non essere materia di inquisizione il dire del p. Bernardo sebbene superiore di Fra’ Michele». La sentenza è perentoria: né vinti né vincitori. Molto fu lo stupore e grande il chiacchiericcio. In novembre Fra’ Michele lascia la “Nunziata” per servitù in San Maurizio (Imperia). E l’asino, compagno di avventura e testimonio attendibile dei fatti, restò in attesa di un nuovo padrone. (dal processo Pro Fratrum Fr. Civilium n. 251-253 A.V.V.)
LA VOCE INTEMELIA anno LV n. 6 - giugno 2000
In quel torbido Seicento, anche all’interno delle famiglie prosperavano comportamenti sanzionatori, intesi a mantenere integro l’avito patrimonio, a vantaggio del figliolo maschio cadetto, il quale avrebbe dovuto perpetuarlo, certamente a svantaggio, ma semmai con la collaborazione dei numerosi altri figli, invogliati a dar gloria al casato attraverso pratiche militari o clericali.
I FRATELLI EMANUELE E PAOLO PORRO
di Nino Allaria Olivieri
Figure che meriterebbero dagli storici ventimigliesi essere tratti fuori da quell’oblio, retaggio di chi per vocazione e scelta sacerdotale pone la propria esistenza al servizio dei fratelli.
Emanuele e Pietro Paolo furono fratelli e sacerdoti nell’Ordine Teatino; figli del nobile Nicolò Porro, uomo di elevata cultura e attento amministratore nel Consiglio dei probiviri che alla cultura univa rettitudine di vita e senso della famiglia. Moriva in Ventimiglia nell’anno 1646 confortato dalla presenza del figlio maggiore Emanuele, e dagli altri tre figli. Di lui il Lanteri scrisse: «visse rettamente e diede ottima educazione ai figli».
Emanuele fu il primo ad allietare la casa del riguardevole Nicolò. Giunto all’età di appena sette anni venne affidato ai Francescani Conventuali affinché apprendesse “il vivere da buon giovanetto di ottima famiglia e il computare e lo leggere la lingua latina”. Fra’ Alfonso nel libro “La provincia di Genova dei frati minori”, ricordando la scuola francescana in Ventimiglia, relazione brevemente del Porro.
All’età di diciotto anni si iscrive presso gli Agostiniani, ma la frequentazione sarà di breve durata. Compiuti gli anni venti e ottenuta licenza dal padre, entra fra i Chierici Regolari Teatini in Cremona.
Trascorre il periodo del probandato in Cremona e al termine, vestito l’abito dell’Ordine, è inviato a Sant’Andrea in Roma; era il 2 luglio 1615.
In Roma, superato il tirocinio filosofico e teologico, viene consacrato sacerdote. Inizia la sua missione presso le case dell’Ordine: superiore in Ferrara per sei anni e in altre città. L’anno 1656 allo scoppio della pestilenza che colpì Genova dal settembre 1656 al settembre del 1657, Pietro Porro opera in Genova, assiste gli appestati e dà ricovero ai fanciulli orfani. Colpito dal morbo morirà in Genova sul finire dell’anno 1657.
Un suo confratello scrisse di Lui: “mentre dopo essersi fatto povero della sua nobiltà e ricchezza, si fece servo della più meschina povertà di Genova per desiderio di ingrandirla con il tesoro della divina grazia”.
Anche il fratello Paolo nato in Ventimiglia l’anno 1600, spinto dall’esempio del primogenito e di altri concittadini divenuti teatini, chiede di entrare nell’Ordine; è accolto in Cremona ove completato il periodo propedeutico è consacrato sacerdote. Opterà per la casa di Milano con il nome di Padre Pietro Paolo.
Per il suo sapere fu a Bologna e a Parma lettore di Sacra Scrittura, a Venezia e a Mantova superiore generale dell’Ordine e a Genova dal 1655, dove si trovava allo scoppio della pestilenza e curò i contagiati con spirito di abnegazione.
Il Cardinale Stefano Durazzo lo nominava esaminatore sinodale del clero. Morirà nell’anno 1675 a Genova in fama di santa vita. Il Rossi nella “Storia della Città di Ventimiglia”, relazionando attorno alla morte di Pietro Paolo, lo dice “Venerabile e ne auspica la beatificazione”. I brevi cenni biologici riportati e il tempo del loro operato coincidono con la presenza in Ventimiglia dell’erudito agostiniano P. Angelico Aprosio, imparentato ai fratelli Porro per linea materna. Più giovane e incline a studi profani, pensatore ardito e seguace del pensiero laico cinquecentesco, forse volutamente, aveva rotto ogni legame di parentela con i Porro. È dubbio se mai si fossero incontrati e se da parte dell’Aprosio il dimenticare volesse indicare indifferenza.
Fu Pietro Paolo da Genova ad agire, dopo anni di silenzio, un approccio epistolare di parentela. Le quattordici lettere inviate in Ventimiglia al cugino sono una corrispondenza reverenziale, timorosa, improntata alla richiesta di notizie familiari.
Conosce pause decennali e si riaccende per avere termine nel 1675. Non un accenno letterario, non un plauso all’operare dell’Aprosio e tanto meno un giudizio critico. Aprosio ragguagliava laconicamente sulle novità richieste “tanto care a chi abita lungi dal luogo natio”. Un atto di squisita educazione.
Padre Ludovico Antinori, teatino, sentenzia sul comportamento dell’Aprosio: “Non fu che il risvegliarsi nell’animo del dotto agostiniano di celate vertenze fra i Porro e gli Aprosi”.
Dovremmo chiederci: “a tanto obbliga la nobiltà ?”
LA VOCE INTEMELIA anno LVIII n. 6 - giugno 2003
L’Ostia consacrata di Forte del Colle - 1611
di Nino Allaria Olivieri
Un foglio di ridotta superficie, notizie telegrafiche vergate in un latino curiale, tema di una certa curiosità storica, resta numerato, quasi sbiadito dal tempo, nel faldone n. 2 civilium, anni 1610-1622 dell’Archivio della Curia di Ventimiglia.
Rivisitarlo e inserirlo tra i fatti ora sereni ora luttuosi, che segnarono i primi decenni del sec. XVII è fare rivivere in tutta la sua realtà un pezzo della storia di Ventimiglia, soggetta alla dominazione genovese.
Era l’anno 1611, il 28 del mese di marzo; nel Forte del Colle un folto gruppo di miliziani corsi genovesi, in meritato ozio, sono alla custodia della città. Il Governatore, uomo di conosciuta severità e alterigia, è in missione in Genova. L’anziano, capo dei bombardieri, è responsabile ed esecutore degli ordini; i soldati sono tenuti “alla tenda” e i prigionieri sorvegliati “notte e giorno”.
Solamente Fra’ Paolo da Camogli ha libero accesso “ma a giorno chiaro” e, quale delegato dalla Serenissima, espleta il compito di Cappellano e confessore. Tre volte alla settimana sale dal sottostante Monastero dell’Annunziata “per esercitare i sacramenti della Parola e della confessione”.
Un “certo penitente” dirà al vescovo Spinola, (si noti la prudenza nel narrare e non poteva essere diversamente perché il fatto rientrava nel segreto di confessione) mi presenta in actu confessionis un pezzo di Ostia consacrata, asserendo lo stesso penitente che la teneva sul petto presso di sé in una pezzuola serica per rimedio di difesa durante i tormenti”.
Fra’ Paolo impone la consegna dell’Ostia consacrata che “mi presentò - dirà al Vescovo - nella accennata pezzuola seria, chiusa in una scatoletta in legno”.
Fra’ Paolo si porta presso il Vescovo. Con passo lento e in silenziosa preghiera percorre il lungo tragitto che dal Fonte immette nella città; chiede di essere ricevuto anche se quella non era l’ora indicata e fa conoscere al famiglio la ragione del suo tardo importunare. Il Vescovo concede l’udienza e, conosciuta la ragione, si inginocchia in venerazione all’Ostia, che Fra’ Paolo depone nelle di lui mani.
E chiamato il notario curiale Giuseppe Lanteri e i testimoni Onorato Rostagno di Mentone e Agostino Curlo di Ventimiglia, sacerdoti espressamente nominati. Seduta stante il Lanteri nella cappella del vescovo attua la narrazione del fatto e la volontà del Vescovo; con giuramento, toccata la piccola scatola contenente l’Ostia, si sottoscrivono.
Il vescovo impone ai sacerdoti presenti di vestire gli abiti liturgici “et accensis Luminibus exportari species sacramentales processionaliter in Ecclesia Cattedralis”. Ciò che avrebbe dovuto svolgersi in segreto divenne di conoscenza pubblica. I pochi fedeli che si trovavano in Chiesa divulgarono l’accaduto tanto insolito. Si legge in calce all’atto notarile: “le sacre specie furono riposte dal Rev.do Agostino sacrista canonico della Cattedrale, dentro il tabernacolo”.
L’accaduto generò supposizioni in città; molte furono le dicerie e non pochi collegarono il fatto agli avvenimenti accaduti in Ventimiglia due mesi prima.
Il penitente non poteva che essere un ecclesiastico conosciuto, forse amato, forse odiato, ma nella sua reità uomo di fede. Nel giustificare il possesso dall’Ostia sul petto dirà “per avere forza nel sopportare i tormenti”. Non solo tormenti morali bensì fisici, quali percosse, catene e ceppo, poco cibo e nessun rispetto.
Chi era costui ? Un documento datato 10 marzo 1610 detta: “Illustrissimo Governatore, il vescovo di Ventimiglia domanda braccio secolare e opportuno da VS. Governatore per far carcerare il Rev.do Ascanio Aprosio, Prevosto della Cattedrale, come dispregiatore delle Censure Apostoliche e dei debiti ordini di Signoria fatti allo stesso Prevosto, altrimenti portati con buona pace dalla signoria Vostra attorno alla denigrazione di quello dovuto secondo le disposizioni dei sacri canoni e per conto suo ne vennero scandali. Da Ventimiglia il 10 marzo 1610”.
Il carcere per il Prevosto Ascanio fu conseguenza della sua ostinazione a non volere versare alla mensa vescovile “la Decima Annuaria” imposta dalla santa Sede al clero dotato di benefici. Al tempo la “Decima annuaria” era una tassa gravante sul beneficio, in parte di spettanza alla Camera Apostolica e in parte al Vescovo per il proprio sostentamento.
Nel suo rifiuto il prevosto Aprosio si appellava e si faceva paladino presso i canonici della tesi, comune a molti ecclesiastici, che una simile imposizione o tassa, oltre ad essere un gravoso balzello rientrava nei vari temi propri al peccato di simonia.
Per la nostra storia non restano documenti processuali. Arrestato e destituito dal beneficio il parroco Aprosio, venne nominato prevosto alla Cattedrale il sacerdote Benardino Lamberti che amministrò dall’anno 1612 al 1634. Quanto tempo restò egli prigioniero ? … e per quale ragione nelle prigioni del Forte del Colle ?
Ho cercato una risposta sfogliando le carte del Capitolo: il nome dell’Aprosio scompare dal novero dei canonici. Si può supporre che tornato in libertà, umile e sottoposto al Vescovo, abbia esercitato presso una cappella campestre.
L’essere rinchiuso al Forte del Colle era conseguenza della richiesta da parte del Vescovo del braccio secolare e della gravità del reato. Poteva l’Aprosio essere rinchiuso nelle carceri del fisco ecclesiastico, oppure essere la sua condanna commutata in mesi di esercizi spirituali presso il Monastero dei Gesuiti in San Remo; la gravità del reato a norma dei sacri canoni e delle bolle papali escludeva ogni condono o mutamento di pena.
Al pari dell’Aprosio nei primi quaranta anni del secolo XVII nel Forte vennero incatenati: un certo sacerdote Maria Paolo della Bordighera e il diacono Fenoglio, della nobile famiglia Ventimigliese, reo di aver violato notte tempo con arma alla mano una certa abitazione di una certa “damigella di grande virtù”. Del processo e della condanna restano tutti gli incarti, esempi di capacità investigativa e serietà e prudenza nell’accusare e nel difendere.
LA VOCE INTEMELIA anno LVIII n. 10 - ottobre 2003





