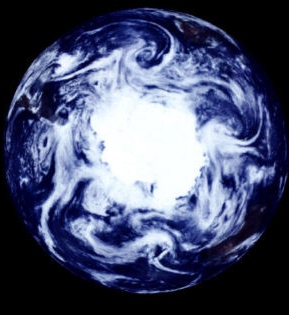 |
SOLSTIZIO
d'INVERNO |
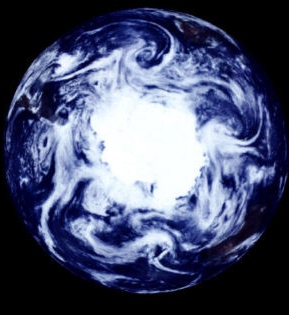 |
USANZE SOLSTIZIALI
INVERNALI
Luigino Maccario - 1990
IL SOLSTIZIO INVERNALE NELL’ANTICA EUROPA
Le manifestazioni che sempre meno fuggevolmente si accompagnano all’attuale religiosità natalizia, anche nei villaggi delle Vallate Intemelie, sono retaggio di antichissime ritualità praticate già dalle popolazioni preromane del nostro continente; che non sono mai state del tutto domate dalle indicazioni ecclesiali, intese a rassettare quelle che oggi ci sarebbero suggerite come le “radici d’Europa”.
Con l’istituzione del Natale, fissato al 25 dicembre, attorno all’anno 340, Papa Giulio I ha tentato di rendere cristiana la diffusa celebrazione della “Rinascita del Sole”, col celebrare la natività del Cristo, in qualità di “Sole di giustizia”. In quel tempo, tutti paesi dell’attuale continente europeo era un fiorire di riti tesi a esorcizzare il fatale sopraggiungere della notte più lunga dell’anno, col richiamo mistico verso il nascente Sole vittorioso sulle tenebre.
 |
 |
 |
Sul continente, collegati tra loro e a volte sovrapposti, i due temi più diffusi erano: la morte del Vecchio Sole, con la nascita del Sole Bambino; o semmai, la sconfitta dell’Agrifoglio, simbolo dell’Anno Calante, ad opera della Quercia, allegoria dell’Anno Crescente. Un terzo incentivo era dettato dalla necessità di preservare la futura germinazione del Grano, quale entità trascendente.
Intanto che il Sole mostrava percettibilmente di ridurre il suo calore e la sua luce; segno di indubbio declino, si rendeva necessario cacciare l’oscurità, prima che provocasse la totale scomparsa dell’Astro. Quelle genti, ritenendo che ogni loro più piccola azione potesse influenzare le grandi sequenze del cosmo; celebravano riti per assicurarsi la rigenerazione solare, con l’accensione di grandi falò, che attraverso la “magia simpatica” avrebbero assecondato la rinascita e provocato la ripresa del cammino solare.

LE RITUALITÀ INTEMELIE
In questo nostro tempo, molti villaggi delle Valli Intemelie hanno ripreso la tradizione di accendere u Fögu d’u Bambìn, nella notte del Solstizio o, quanto meno la sera della vigilia di Natale.1 Anteriormente al Secondo Conflitto Mondiale, non vi era luogo abitato che non provvedesse a far ardere questi fuochi rituali; usanza che è stata contrastata da indistinte autoritarie indicazioni, tese a scongiurare ogni rischio d’incendio, verso le case a ridosso; quelle stesse costruzioni che avevano sopportato secoli di scoppiettanti falò.
Nell’immediato dopoguerra, l’usanza è rimasta in vita in molti centri che non avevano patito un qualche esodo, ma il cambiamento di vocazione nell’economia valliva la ha fatta visibilmente retrocedere.
Oggi, i paesi che dispongano di una larga pubblica piazza, hanno ripreso ad accendere il fuoco e, molti tra questi, lo alimentano almeno fino all’Epifania, come era nell’usanza generale. Consuetudine che in passato, vedeva alcuni luoghi attrezzarsi, così da protrarre l’ardere del falò fino al 2 febbraio, giorno della Candelora.2
La preparazione del falò, fino all’accensione, era esclusiva prerogativa maschile. Fin dall’inizio di novembre, i giovani del paese si davano cura nell’accatastare, in un opportuno cantone della piazza, tutti gli scarti lignei del lavoro agricolo, adocchiati durante il loro girovagare nel contado.3
Gli anziani entravano in campo nella giornata della vigilia, provvedendo ad allestire un opportuno grande falò, che incanalasse la sua lunga fiamma al centro della struttura. All’imbrunire si avvicinavano le donne e le ragazze del paese, che sedevano attorno alla pira, ad opportuna distanza, nell’oscurità, attendendo gli uomini che giungevano con la fiamma sacrale della candela con la quale sarebbe stato acceso il falò.
Durante la giornata le donne, in casa, avevano spalancata la madia, per soddisfare il rituale della preparazione del pane, conforme al sopraggiungere, nel giorno successivo, a quella che s’intitolava a giurnà d’u pan; il sacrosanto giorno del pane, nel periodo solstiziale che intendeva preservare la futura germinazione del Grano.
Dopo aver confezionato grossi pani, sufficienti a coprire il consumo nei pranzi festivi, in ampi frammenti di impasto aggiungevano: pinoli, pezzi di mandorle e buccia di agrumi candita mista ad uvetta, per confezionare il pandùçe, quel dolce rimasto vivo soltanto nella tradizione genovese: quello con il rametto d’alloro, l’auribàga, in mostra nel bel mezzo delle tre incisioni benauguranti, fatte sul culmine dell’impasto, che nella cottura, dessero forma ad un triangolo privo di angoli, dai numerosi significati esoterici.

I RITUALI VENTIMIGLIESI
L’accensione del falò si perpetuava anche in piazza della Cattedrale, in Ventimiglia, ma la dispersione dell’usanza era già confermata nei primi anni del Novecento, a causa dell’esodo di numerose famiglie verso le moderne abitazioni d’u Cuventu.
Quando la città era ancora racchiusa nelle mura Cinquecentesche, per tutto l’Ottocento si è mantenuta viva anche l’usanza che riguardava i bimbi, o meglio gli adolescenti. Questi all’imbrunire del giorno di vigilia, si riunivano in numerose masnade, dette e ströpe, per scorrazzare tra vicoli e chintàgne, di casa in casa, al canto di una filastrocca natalizia, che Emilio Azaretti ha mantenuto in vita, inserendola in una sua canzonetta degli Anni Venti.4
Si tratta di una cantilena di questua, proposta dai bimbi con una certa invadenza, che invitava le donne di ogni casa a fornire un dono, una piccolissima strenna, da ricercarsi tra le materie prime nella fabbricazione del pandolce, che in quel momento stava lievitando ìnt'u tòuru, la madia nostrana.5
Se non si fosse velocemente soddisfatta l’ingordigia della masnada, non si sarebbe ottenuto il risultato di farla proseguire per altre case, togliendosi d’attorno i piccoli invadenti.

______________________

Nella tradizione medievale ligure, esisteva una bevanda, col nome di clàrea, termine che rispondeva al significato di gradevole pozione che gli speziali erano obbligati a preparare nel Natale.6
Dunque il Natale veniva popolarmente festeggiato bevendo un intruglio che la legislazione della Serenissima Repubblica poneva in commercio, obbligando gli speziali a produrla.
Molti popoli dell’Europa medievale si rifacevano ai riti celebrativi del Solstizio d’inverno, con corpose bevute di una pozione speziata e zuccherata, tanto che il lemma giule, che troviamo nelle voci derivate dall’arabo giuleb porta ai termini: giulebbe, col significato di pozione fatta con acqua e zucchero e cotta a giusta consistenza; ma anche: giulebbare, che riflette cuocere nello zucchero, ma anche conciare per le feste.
Tra i Celti delle isole, una ricorrenza situata a cavallo dello stesso Solstizio, che veniva chiamata “Yule”, prevedeva riti di iniziazione assai simili ai Saturnali romani, riti che possono essere stati inglobati nel nostro Natale medievale.
Purtroppo non ci è dato di conoscere la totale composizione della bevanda che ha caratterizzato i nostri Natali medievali, anche se sappiamo che tra gli ingredienti era il gingìberu, una spezia aromatica per bevande dal nome anch’esso di derivazione araba.
 |
 |
IL GIOCO D’AZZARDO
Negli Statuti medievali di molti comuni del Ponente ligure, il gioco d’azzardo, specialmente se condotto coi dadi, era severamente proibito ed avversato con pesanti sanzioni pecuniarie, fino ad arrivare al carcere per coloro che fossero recidivi. Soltanto dalla festività di San Tommaso, il 21 dicembre, era consentito il gioco d’azzardo, licenza che durava, in qualche caso, fino al Capodanno ed in altri fino all’Epifania.
Erano questi i retaggi dell’antico mito di Saturno e della corrispondente Età dell’Oro, in auge ancor prima dell’avvento di Roma. Giacché, ancora in periodo imperiale, durante i Saturnali, la statua della divinità presente nei templi veniva fasciata ed al suo posto governava quei giorni il “rex Saturnaliorum”, un sacerdote che veniva infine simbolicamente immolato per dare fine al ciclo cosmico, a termine del quale la divinità creativa ritornerà sulla terra a ripristinare quell’Età. In questa luce si situa l’usanza romana di permettere il gioco d’azzardo soltanto durante i Saturnali.7
I Romani avevano identificato Saturno con la loro Fortuna, espressione di una volontà divina e non del capriccio del caso, mettendolo in stretta connessione col gioco d’azzardo, sicché, al “gioco era connessa anche la festa dei “Larentalia” che si celebrava il 23 dicembre, ultimo giorno dei Saturnali, legato alla leggenda di Acca Larentia. 8
Sarebbero state queste le radici delle tombole natalizie, sbiadito ricordo dei gioco rituale legato ai Saturnali. Attestato dagli Statuti di Apricale del 1430, “… a vigilia nativitatis Domini ad epiphaniam possit ludere ad avelanas”, nei giorni che correvano dal Natale all’Epifania, era usanza giocare con le nocciole, attorno al fuoco.
La tradizione per la quale gli antichi popoli mediterranei sospendevano ogni lite durante i quattordici giorni a cavallo del solstizio invernale, potrebbe aver radici profonde persino nel nostro costume.9
NOTE :
1) Col termine dialettale “bambìn” viene definito il simulacro dell’infante che, al termine della messa notturna natalizia, viene posto in ostensione dentro una culla elaborata quale luminosa raggiera, dopo aver ricevuto il bacio del pubblico.
2) La quasi esclusiva vocazione agricola, nei villaggi intemelìi d’anteguerra, metteva a punto la quasi totale disponibilità di tempo degli uomini del posto, che organizzandosi in appropriati turni, assistevano la fiamma giorno e notte, non mancando di intrattenere gustose distrazioni con il racconto delle immancabili leggende.
3) Quando la sera dell’accensione, la riserva non fosse stata abbastanza fornita, i giovani davano sfogo alla loro conforme spensieratezza, andando nottetempo, a prelevare oggetti legnosi ancora in uso; badando nel frattempo a raddrizzare i comportamenti poco sociali di individui, per quello ben conosciuti in paese. Avendo assistito ad alcuni falò in Camporosso; ricordo il festoso sopraggiungere di quattro giovani scalmanati che sorreggevano una voluminosa porta, gettata immediatamente tra le fiamme, quasi immediatamente seguiti dal giungere affannato di Baci, che reclamava “a porta d’u mei stagiu”. Rivelandosi Bacì elemento piuttosto asociale, d’intorno al fuoco nessuno pareva neppure vederlo, tra una trascinante ilarità generale.
4) Il ritornello di questa antica canzone è riportato a pag. 31 di CANSUN VENTEMIGLIUSE, pubblicato dalla Cumpagnia nel 1970.
5) L’usanza è assai simile a quanto Hallowéen ha riportato tra noi dall’America; quel “dolcetto o scherzetto” che ormai si ripresenta puntuale ad ogni fine ottobre. Negli antichi rituali capodanno era consueto che le anime dei morti giungessero tra i vivi per portare a termine quanto avevano lasciato incompiuto, andandosene. Allora si dava spazio ai bimbi, i quali con l’arma della loro ingenuità, sarebbero stati gli esseri più adatti ad informare i viventi sulla “emergenza” di un simile momento spazio-temporale. Per questo Hallowen e la Stròpa si somigliano. I bimbi informavano i viventi sul sopraggiungere dell’anomalia, ma in compenso pretendevano un compenso, ossia la questua che retribuiva il loro “lavoro”. Nei primi anni dell’Ottocento, con l’avvento dell’Impero Napoleonico e lo spostamento dei cimiteri fuori dell’abitato, la ritualità della “ströpa” perse vigore e soprattutto un’indicazione temporale precisa.
6) Notizie sulla “clarea” si trovano nel Glossario Medievale di Girolamo Rossi.
7) Come osserva Margarethe Riemschneider, il gioco d’azzardo era un atto rituale in stretta connessione col dio, e soltanto a poco a poco, dopo modifiche e aggiunte, venne introdotto nel banchetto privato e considerato un divertimento. La stessa aggiunge: “Ci è noto come il gioco d’azzardo, tanto nel culto quanto nel mito; un tempo però era una prerogativa degli dèi o del re, loro rappresentante in terra.
8) Da Plutarco apprendiamo come sotto il regno di Anco il custode del tempio di Ercole sfidò il dio a dadi, facendo da solo la parte di ambedue, ma ponendo come condizione che il vinto pagasse una cena ad una meretrice. Vinse Ercole, e allora il custode chiuse nel tempio Acca Larentia, allora celebre cortigiana, insieme con una cena. Il dio venne davvero, e il mattino dopo le ordinò per riconoscenza di recarsi al mercato e di abbracciare il primo che le fosse venuto incontro. Questi fu un certo Tarrutius, uomo già avanti negli anni, ma scapolo e dal patrimonio considerevole. Egli le si affezionò così tanto da nominarla erede di tutti i suoi beni che poi Acca Larentia lasciò morendo al popolo romano.
9) Quei giorni erano chiamati in latino “alcyonei dies”, quando il mitico uccello marino poteva costruire il proprio nido tra gli scogli molto vicini alle onde, che le divinità rendevano in bonaccia per l’occasione, greci e romani chiudevano persino i tribunali. L’alcione, il mitico uccello che proponeva tale antichissima usanza, nel nostro dialetto è conosciuto come “margun”, quello smergo maggiore che nidificava anche sulla Pria Margunaira. Ora, quella pietra, unico grande scoglio presente in acqua sul litorale ventimigliese, non avrebbe assunto un nome così legato a quel mito, se la relativa tradizione non fosse stata assai vivace tra la gente intemelia.
a partire da INTEMELION n. 7/8 - 2001/2 - Archivio d. memoria p. 163





